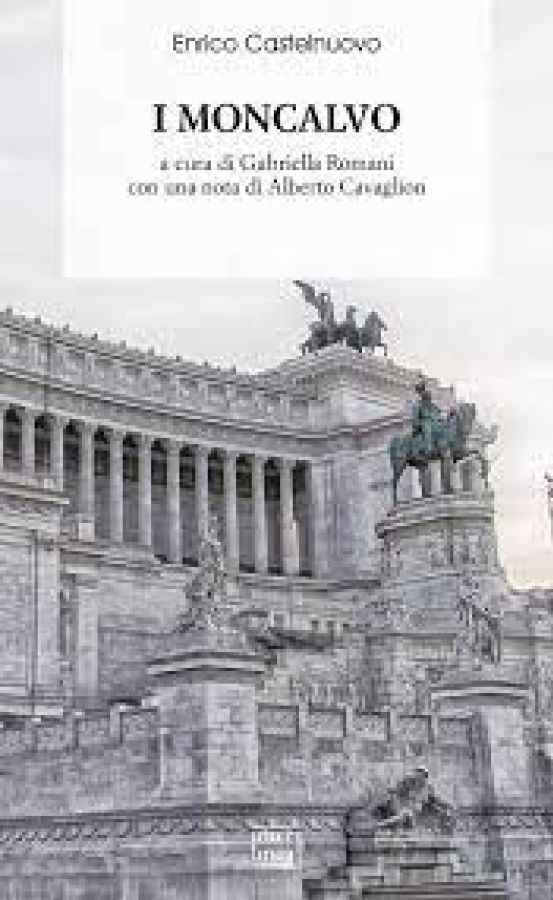Il romanzo è ambientato a Roma alla fine dell'Ottocento. E' ancora forte la rottura tra la Chiesa e il nuovo Stato italiano, ma la frattura si va lentamente ricomponendo nel crescente clima di affarismo e nazionalismo che pervade la classe dirigente. Di umili origini, un tempo rinchiusi nel ghetto, "all'ombra delle nostre vecchie sinagoghe, isolati in un mondo ostile", i due fratelli Moncalvo, Giacomo e Gabrio, si sono affermati nella società, seguendo però strade differenti: Giacomo ha fatto una brillante carriera in campo scientifico, ottenendo riconoscimenti accademici anche se non economici, Gabrio si è arricchito enormemente in Egitto per tornare a Roma e divenire un esponente importante dell'alta finanza. Sono diversi approcci alla vita, ereditati da Giorgio e Marianina. Il primo è il figlio di Giacomo e, come il padre, è dedito allo studio e all'insegnamento, indifferente alla ricchezza, morigerato e intriso di valori morali. Marianina, figlia di Gabrio, è ambiziosa, amante del lusso e dei salotti dell'alta borghesia, pronta a tutto pur di ascendere nella scala sociale. Domina un comune "indifferentismo" religioso. I Moncalvo si sentono ebrei più per tradizioni familiari che per fede e pratica. E' un tratto ricorrente in molta borghesia ebrea, desiderosa di integrarsi e influenzata dai valori positivistici, nazionalisti e affaristici di fine Ottocento. A pregiudicare la fragile unità familiare è la conversione di Marianina al cattolicesimo per poter sposare un esponente dell'aristocrazia "nera", così definita perché legata al Vaticano, e acquisire in tal modo il rango di principessa, entrando a far parte dell'alta società. E' un progetto dei genitori, ma è la ragazza a perseguirlo con determinazione e consapevolezza sorprendenti per una viziata e ricca ereditiera. Nel corso del romanzo Marianina è definita come un "Lucifero", una "Sfinge", una personalità misteriosa e sconcertante per gli stessi genitori. Per tentare di comprenderne il carattere bisogna soffermarsi su un colloquio tra i due cugini. Giorgio è sconvolto dalla passione, "ella gli avrebbe dato un'ora di ebbrezza, ed egli, il rigido scienziato, travolto da un vento di follia, chiedeva a sé stesso se per avere quest'ora non convenisse sacrificare tutta la vita". Nella sua presunzione Giorgio pensa di dare con il suo amore "una tavola di salvamento" ed evitare che la cugina si getti "in un baratro di viltà e di menzogna, comprando "un misero blasone a prezzo del tuo corpo e della tua anima". "Ella si strinse nelle spalle. Tu vaneggi (disse). (...) Il mio cuore non è di nessuno. (...) Dovevamo crescere nella vecchia città di dove sono originarie le nostre famiglie, entro il vecchio recinto che chiudeva la gente della nostra razza, (...) ristretti di ambizioni d'idee, fidenti solo nella missione del nostro popolo....Allora sì avremmo potuto sposarci ed esser felici.... Oggi è impossibile". Emblema di un femminismo audace, Marianina è una personalità dell'avvenire, figura moderna e libera.
Il romanzo termina con le amare considerazioni di Giacomo sull'intera società italiana di fine Ottocento. "Quasi da per tutto era un abbassamento dei caratteri (pensa l'austero professore), un naufragio delle convinzioni, un cinico disprezzo delle virtù eroiche della rinuncia e del sacrificio, una corsa sfrenata verso gli effimeri onori e le improvvise ricchezze..." Era probabilmente questa la finalità di Castelnuovo nello scrivere la storia dei Moncalvo, e questa impronta moraleggiante ha portato molti critici a definire come "ideologico" il romanzo: una contrapposizione tra gli eredi dei valori risorgimentali, ormai in dissoluzione, e la nuova classe sociale, cinicamente rampante; il tutto intriso di toni melodrammatici (si pensi alla figura di Giorgio) e di timbri dannunziani (quanto Marianina assomiglia a Sibilla Aleramo!). E' una interessante rappresentazione dell'Italia giolittiana; inoltre, il romanzo spiega l'attitudine della borghesia ebraica ad accettare i valori dominanti sino a non vedere gli elementi razzistici del fascismo. Solo per questo sarebbe interessante leggere il libro. La figura enigmatica di Marianina dà qualcosa di più, ci fa intravedere un carattere complesso e affascinante.
Lo stile letterario è asciutto, distinguendosi dalla prevalente retorica della letteratura italiana di fine Ottocento. E' un pregio da non sottovalutare.
Perché leggerlo? Interessante dal punto di vista storico, splendida la figura di Marianina.