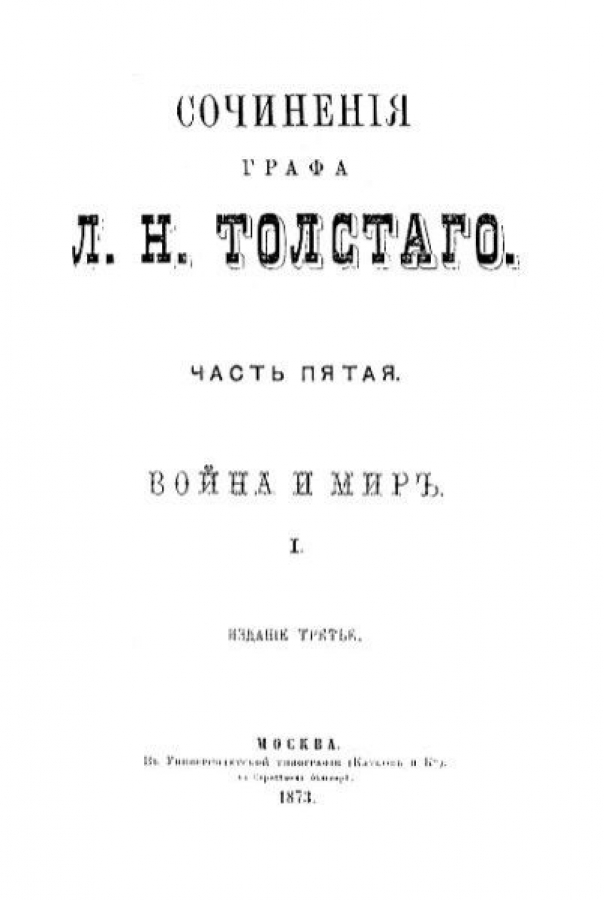
Il libro tratta delle guerre napoleoniche e in particolare dell’invasione dei francesi della Russia, del saccheggio di Mosca e della sconfitta di Napoleone.
Nelle prime parti del romanzo la guerra è qualche cosa di lontano, una questione dei potenti, dei loro giochi diplomatici, mentre "la vita, la vera vita degli uomini, con le sue necessità fondamentali concernenti la salute, la malattia, il lavoro, il riposo.
..
, si svolgeva, come sempre, indipendentemente e al di fuori dell’amicizia e dell’ostilità politica con Napoleone Bonaparte e al di fuori di tutte le possibili riforme".
Esistono quindi diversi piani di narrazione:i grandi fatti politici e militari, le battaglie e le rivalità politiche, narrando le quali Tolstoj esprime sin dall’inizio uno dei temi fondamentali del libro.
La sua filosofia della storia è che tutto si compie sulla base di un fine, che è non è dato agli uomini comprendere, perché opera della Provvidenza Divina.
Questa concezione filosofica contrasta, poi, con l’evidente rappresentazione della guerra come distruzione, sofferenza e morte, ossia una catastrofe, che non salva né vinti né vincitori;la vacua vita della corte e degli aristocratici, rinchiusi nel loro sistema di relazioni, nei piccoli piaceri mondani e negli intrighi: tutti comportamenti che continuano durante lo stesso saccheggio di Mosca, noncuranti del pericolo che incorre sul paese;la ricerca di una spiegazione dell’esistenza, che viene rappresentata da Pierre (la massoneria e le idee della democrazia francese), dai tormenti del principe Andrea (che coglie sin dall’inizio l’assurdità della guerra e fugge inorridito), dalla fiducia nella religione della principessa Maria;la vita familiare dei Rostov, fatta di piccoli fatti autentici, della scoperta dell’amore di Nastascia, dell’affetto infelice di Sonja per Nicola, delle prime infatuazioni, delle feste e dei ricevimenti.
Questa struttura del romanzo si rompe con l’invasione dei francesi, quando la guerra entra nella vita civile.
Come dice il principe Andrea, "anche mio padre faceva costruire a Lissia Gori e credeva che quello fosse il suo posto, là fosse la sua terra, la sua aria, fossero i suoi contadini; ma venne Napoleone e, senza sapere della sua esistenza, lo urtò, gettandolo, come una scheggia, fuor dalla strada e crollarono Lissia Gori e tutta la sua vita”.
La guerra rimescola i diversi piani narrativi del romanzo e sconvolge la vita dei protagonisti, aprendo percorsi che sembravano impossibili, ma sono resi possibili dalla sofferenza, dalla necessità e dall’autenticità che viene richiesta dai fatti eccezionali.
Maria viene salvata da Nicola e se ne innamora, Pierre capisce nella prigionia, a contatto con le privazioni, la morte e le persone semplici, le radici della serenità e della felicità, Natascia conosce l’amore assistendo Andrea e coglie gli aspetti veri, e non superficiali, del rapporto di amore e quindi si prepara ad accettare l’affetto di Pierre.
Tutto si conclude nella scoperta della valori fondamentali (la famiglia, il matrimonio, il piacere della campagna e della buona gestione, la religione) in un "osanna" della tradizione e del bene.
La forte impronta religiosa e filosofica va a detrimento della profondità e complessità dei personaggi e delle vicende narrate.
I protagonisti sono stereotipi di ruoli sociali e familiari e non emergono tormenti reali, effettive evoluzioni e cambiamenti.
Il ritmo della narrazione è veloce, se si escludono le digressioni filosofiche, ma ciò è dovuto a una successione di episodi, che, in certi casi, decadono in flash estemporanei rispecchiando, paradossalmente, la struttura di una fiction moderna.
Si salvano alcune pagine: la visita di Nicola all’ospedale militare con la visione degli infermi in condizioni igieniche spaventose, la battaglia di Borodinò, la mescolanza tra soldati russi e prigionieri francesi, ricondotti a un unico destino, la morte di Andrea e i tormenti di Maria e di Natascia.
Da questo punto di vista non si può condividere l’opinione espressa nell’Enciclopedia Treccani, che volge in positivo ciò che è invece il più profondo limite dell’opera.
"Ciò che maggiormente colpì e colpisce in questa epopea a motivi ricorrenti e pur sempre nuovi, è l’assenza in essa di ogni arbitrio d’arte, il fondersi completo dell’arte con la vita.
Sostenute da una prosa tutta sostanza e senza ombre di orpelli, le diverse fila del racconto si annodano e disciolgono con spontaneità assoluta.
Vi si celebrano con la stessa devozione, umile e solenne, la vita e la morte.
Dai protagonisti alle comparse, tutti hanno una loro inconfondibile individualità, e tutti, a loro volta, sono come assorbiti da una umanità che è in essi e sopra di essi.
Soltanto verso la fine del romanzo si avverte la presenza dell’autore che ha una tesi da difendere e da predicare.
E questa presenza sarebbe invero urtante, se essa non ci riportasse all’essenza stessa dell’opera: l’uomo non crea nulla, non domina nulla, egli segue la marcia inevitabile dei fatti che si svolgono dinanzi ai suoi occhi".
L’attualità del romanzo sta nella dolorosa rappresentazione della guerra, nei suoi effetti devastanti sui soldati e sulla società civile.
In questo senso il tema dicotomico della guerra come un insieme di eventi lontani, che non toccano le coscienze, e della guerra come ingresso violento nella vita quotidiana costituisce un elemento di riflessione valido anche per l’attuale situazione politica.
Tolstoj non condanna la guerra in se stessa (è evidente il suo apprezzamento della guerra partigiana e la concezione romantica della guerra come liberatrice dei valori autentici), ma sembra, soprattutto, condannare la guerra come "gioco" diplomatico e politico, che trascura l’impatto di sofferenza e di dolore sul popolo.