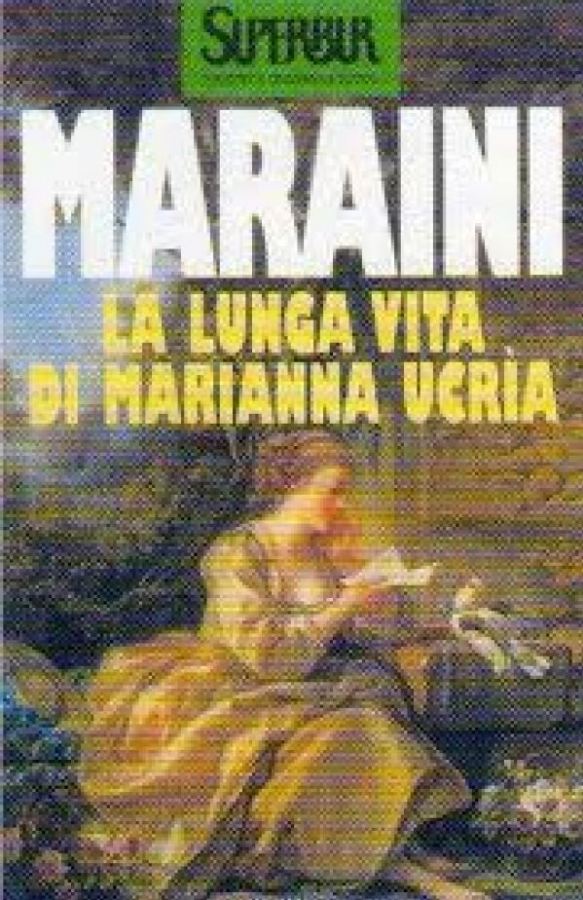
Siamo nella Sicilia del ʼ700.
Marianna appartiene ad una ricca famiglia aristocratica di Palermo.
È sordomuta, ma la sua menomazione non le ha impedito di essere una donna decisa, colta, corteggiata e alla fine indipendente, capace di non tener conto delle regole e dei costumi della società del suo tempo.
Anzi, " la menomazione lʼha resa più attenta a sé e agli altri, tanto da riuscire talvolta a carpire i pensieri di chi le sta accanto".
Vorrebbe " scrollare la testa per liberarsi di quei pensieri inopportuni, appiccicosi come il succo delle carrube ...
da ultimo ci casca dentro, alle persone, attratta da un certo sfarfallìo brioso dei loro pensieri che promettono chissà quali soprese".
La vita di Marianna si svolge proprio allʼinterno della gabbia che le deriva dalla sua invalidità: da un lato deve costringere gli altri a scriverle, in biglietti ai quali risponde con altrettanti foglietti, e quindi è una relazione filtrata, resa difficile dalla cattiva padronanza della parola scritta da parte dei suoi interlocutori ( la stessa classe aristocratica è spesso quasi analfabeta); dallʼaltro lato Marianna possiede una sorta di potere telepatico, che è ad un tempo lettura labiale, sensibilità dei sensi, immaginazione di una personalità melanconica e solitaria.
Si tratta, tuttavia, di una comunicazione invasiva, che non ha rispetto dellʼintimità della persona.
Apparentemente, la vita di Marianna non ha niente di eccezionale, per quei tempi: si sposa ancora bambina con uno zio, che diventa " il marito zio", ha molti figli, si dedica alla gestione delle sue immense proprietà, preferisce la lettura dei libri alla vita mondana, alla quale partecipa per dovere.
Il matrimonio si consuma in una serie di accoppiamenti senza amore, ma non ha un particolare astio verso il marito zio, anche quando scopre che è stato lui a violentarla quando aveva cinque anni.
Ma è al padre, amato ed ammirato, che Marianna, ormai vedova e donna matura, imputa la sua mutilazione, perché a lui che deve il silenzio su ciò che le è capitato da piccola e un matrimonio raccapricciante, con il suo stesso violentatore.
" Capisce con limpidezza adamantina che è lui, suo padre, il responsabile della sua mutilazione ...
è lui che le ha tagliato la lingua ed é lui che le ha riempito le orecchie di piombo fuso perché non sentisse nessun suono e girasse perpetuamente su se stessa nei regni del silenzio e dellʼapprensione".
Ed è alla fine della sua lunga vita, quando ha scoperto sia lʼamore sensuale che quello letterario, che Marianna abbandona Palermo, sola con una serva pazza.
In giro per lʼItalia si accompagna ad un gruppo di attori e finalmente Marianna " gustava la libertà: il passato era una coda che aveva raggomitolato sotto le gonne ...
il futuro era una nebulosa dentro a cui si intravvedevano delle luci da giostra.
E lei stava lì, mezza volpe e mezza sirena, per una volta priva di gravami di testa, in compagnia di gente che se ne infischiava della sua sordità e le parlava allegramente contorcendosi in smorfie generose e irresistibili".
Enzo Siciliano, un grande critico letterario, colloca il libro nella tradizione di Verga, De Roberto e Lampedusa.
È un accostamento sbagliato.
Il contesto storico, così come la sagra familiare, sono espedienti per narrare dellʼaltro: la solitudine della donna, esasperata dalla sordità e dal mutismo, la lotta per liberarsi, per conquistarsi un proprio spazio in una società gretta, rozza ed ipocrita.
È un romanzo intimistico e contemporaneo, anche per la funzione di redenzione, ma anche di chiusura su sé stessi, che viene affidata alla fantasia.
Ad un certo punto Marianna " legge con il mento appoggiato alla mano" una frase di David Hume in un quaderno, forse dimenticato da un viaggiatore nella sua biblioteca: " lʼintelletto, dice il filosofo inglese, distrugge del tutto sé stesso ...
noi ci salviamo da questo scetticismo per mezzo di quella singolare e apparentemente volgare proprietà della fantasia ( di entrare) negli aspetti più reconditi delle cose".
Lʼimmaginazione è la chiave di comprensione delle cose e il romanzo può essere interpretato, nello stile barocco e nelle descrizioni ricercate e senza tempo, come una fuga continua dalla durezza della vita quotidiana, alla quale ci si ritroverebbe rinchiusi se si facesse affidamento alla sola ragione.
Romanzo, quindi, filosofico, sotto lʼapparenza della storia familiare e del racconto storico ? A questa chiave di lettura inducono anche la struttura narrativa, fatta di bozzetti e di episodi, e la scrittura talvolta ampollosa, immaginifica e affettata.
E sono queste caratteristiche che rendono il racconto prolisso, lento e noioso.
Perché non leggerlo ? È noioso.